Genocidio o no? Davvero è questo il punto?
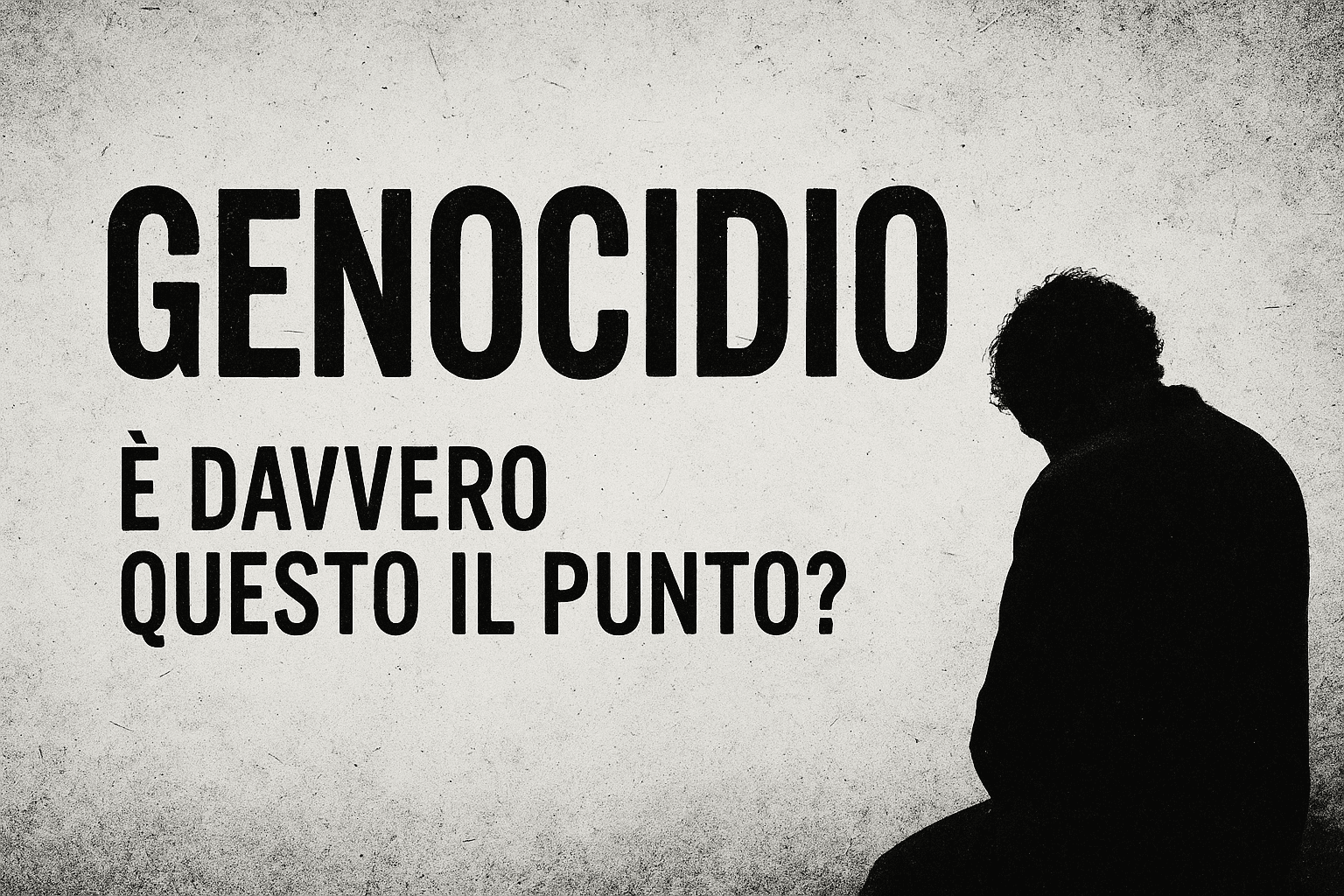
C’è un dibattito surreale che rimbalza da anni tra editoriali, talk show e social network: si può usare la parola genocidio per descrivere ciò che accade a Gaza?
Si mobilitano giuristi, filosofi, semiologi, accademici dell’ONU in pensione e attivisti della punteggiatura. Alcuni dicono che sì, è un genocidio. Altri che no, è una guerra. Altri ancora chiedono di sospendere il giudizio, di attendere le prove, di evitare l’uso “improprio” dei termini.
E mentre i commentatori litigano sulle parole, la realtà muore. Letteralmente.
Ma noi, europei alfabetizzati e impotenti, ci aggrappiamo al linguaggio come a una zattera etica. Non possiamo fermare i bombardamenti, non possiamo modificare le alleanze, non possiamo ridistribuire il potere geopolitico. Però possiamo discutere del termine corretto da usare mentre la gente brucia viva sotto le macerie.
Questo non è un dibattito. È una forma avanzata di placebo morale. Una sofisticata strategia di rimozione collettiva.
Il sequestro è avvenuto. E nessuno l’ha fermato.
Ma perché accade tutto questo? Perché l’ossessione linguistica ha sostituito la decisione politica?
Semplice. Perché il decisore pubblico è stato sequestrato. E non da milizie armate, ma da interessi economici strutturati, opachi, intoccabili.
La scena più nitida e sfacciata di questo sequestro si è avuta in Scozia, nel luglio 2025, quando Unione Europea e Stati Uniti hanno siglato un accordo “di riequilibrio” sulle tariffe doganali nel settore dell’acciaio e dell’alluminio. Un’intesa presentata come necessaria per superare le tensioni commerciali sorte dopo le misure protezionistiche americane, ma che — nella sostanza — ha ratificato una subordinazione sistemica degli interessi pubblici europei a quelli del comparto industriale e militare statunitense.
L’accordo ha introdotto nuove quote e dazi differenziati che danneggiano intere filiere europee in nome della “sicurezza economica occidentale”. Ma nessuno ha spiegato perché le acciaierie tedesche, francesi o italiane dovrebbero essere sacrificate per garantire la stabilità dei margini di profitto delle industrie USA. Nessuno ha chiesto il parere del Parlamento europeo o dei cittadini. Non si è discusso pubblicamente di impatto sociale, occupazionale o ambientale. Si è semplicemente deciso altrove.
E poi comunicato con toni rassicuranti, come si fa con una variazione di listino. Nessun conflitto. Nessuna assunzione di responsabilità.
Ecco il sequestro del decisore pubblico in azione: il potere formale rimane in scena, firma gli atti, partecipa alle conferenze stampa. Ma il potere reale — quello che determina le condizioni materiali della collettività — è stato traslato fuori dalla sfera pubblica, incapsulato in reti di influenza che rispondono ad altri mandati: industriali, geopolitici, speculativi.
Genocidio, parola-ostaggio.
Così anche il termine genocidio diventa un ostaggio. Una parola caricata di senso, svuotata di potere. Il suo uso divide, ma non decide. Serve a occupare spazi vuoti, a dare l’illusione di una presa di posizione. E intanto, la decisione vera è già stata presa. Altrove. Da altri.
In fondo, non ci interessa davvero come si chiama. Ci interessa chi ha il potere di impedirlo. E oggi quel potere non risiede nelle istituzioni pubbliche, ma in centri decisionali extra-istituzionali, capaci di influenzare governi, regolare mercati, condizionare agende e diplomazie.
Come se ne esce? Non con le parole giuste.
Spazioetico lo ripete da anni: la prevenzione della corruzione è impossibile senza integrità nei processi decisionali. E l’integrità è impossibile quando le decisioni sono catturate da interessi che nessuno ha eletto, che nessuno può sanzionare, che nessuno può vedere.
Discutere su genocidio o crimine di guerra, in queste condizioni, è come litigare sul nome del Titanic mentre affonda.
Il problema non è il termine. Il problema è l’architettura di potere che rende il termine irrilevante.
E allora, basta morfologia. Basta semantica. Serve disvelare il sequestro. Serve rompere il nesso tossico tra potere e opacità. Serve una nuova grammatica dell’azione pubblica, che parta da una domanda radicale: chi decide davvero? E per conto di chi?
Perché finché non rispondiamo a questa domanda, ogni parola sarà solo una forma educata di complicità.


